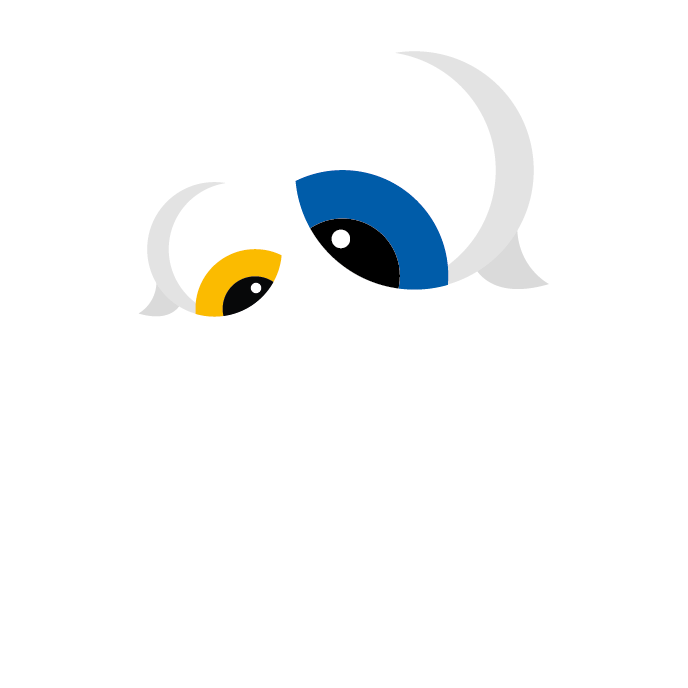“Quando ho dato vita al mio nuovo team l’obiettivo è stato fin da subito creare una squadra con dei valori. Scegliere le componenti prima come persone che come atlete, insegnare loro che esiste un ciclismo internazionale e che lo possono praticare, dando l’opportunità a tutte di farlo, anche a chi in Italia questa possibilità non l’aveva”. Gaia Tortolina ha solo 23 anni, ma le idee molto chiare. Ci parla dal Belgio, dove vive dal 2018 e dove la cultura del ciclismo offre maggiori opportunità, anche e soprattutto alle donne, che in Italia pagano ancora un notevole divario di trattamento, considerazione e visibilità rispetto ai colleghi maschi. Proprio in Belgio nell’autunno scorso ha fondato il Women Cycling Project, una squadra di ciclismo tutta al femminile. Alle ragazze dice: “Difendete sempre la vostra dignità, non fatevi trattare come macchine”.
Di Ilaria Leccardi
Gaia, partiamo dall’inizio, dal tuo avvicinamento al ciclismo che è avvenuto quando eri piccolissima…
Sono nata in un ambiente sportivo e ho iniziato a praticare sport da piccolissima. Mio papà ha giocato a calcio a livello professionistico, poi dopo la mia nascita si è dato al triathlon, coinvolgendo anche mia mamma in questo sport di tenacia e fatica. Li ho sempre visti uscire in allenamento, per me era entusiasmante, era normale volerli emulare. Poi un giorno un amico di mio padre che gestiva una squadra di ciclismo di bambini della zona, la Cicli Tortonese, gli chiese se volevo unirmi a loro. Non avevo ancora l’età per gareggiare, mi allenavo con i maschietti. Non avevo neanche la bici da corsa, ma una piccola mountain bike rosa… È iniziato tutto così, quasi per gioco. E anche se c’erano sport in cui eccellevo più che nel ciclismo, le due ruote sono sempre state il mio amore più grande.
Quando ti sei accorta che non era più un gioco e si iniziava a fare sul serio?
È stato attorno ai 14/15 anni, quando sono approdata alla categoria Juniores, in cui ormai si gareggia a buoni livelli, appena prima del professionismo. Sono sempre stato molto costante. E pur non essendo mai stata un talento eccelso, riuscivo sempre a piazzarmi tra le migliori, una gara dopo l’altra. Sono stata presa in un team di Milano di sole donne. Mi allenavo per lo più da sola, seguita a distanza, e poi mi vedevo con le compagne e il team in occasione delle gare e per dei periodi intensivi di allenamento. Facevamo base in un appartamento dove noi ragazze dormivamo e poi di giorno uscivamo in strada tutte insieme. Il ciclismo – soprattutto su strada – è uno sport particolare, dove l’allenamento non può mai riprodurre pienamente ciò che avviene in gara. Da una parte perché durante la preparazione sei sola, mentre in gara si corre in gruppo ed è quest’ultimo che determina la velocità, nel confronto con le altre partecipanti. Dall’altra perché incidono molti fattori, dal tempo atmosferico alla possibilità di forare o di incappare in una caduta.
Quando è avvenuto il passaggio al professionismo?
Nel 2016, avevo 18 anni. Ho avuto una proposta da una squadra di Asti, di cui sono entrata a fare parte, ma purtroppo non è stata un’esperienza positiva. Volevo crescere, trovare le mie opportunità. Una compagna di squadra belga mi disse: “Vieni da noi, là ci sono tante gare, avrai l’occasione di metterti in mostra”. La mia idea era partire, fare un po’ di esperienza, qualche gara, prendere il ritmo per la stagione e rientrare. E invece… sono ancora qua!
Cos’hai trovato di diverso rispetto al contesto italiano?
In Belgio c’è una grande attenzione all’atleta e una passione verso tutti e tutte coloro che fanno parte del mondo del ciclismo. Sono abituati a vedere ciclisti che arrivano da tutte le parti del mondo per correre da soli ed emergere. Io sono arrivata letteralmente da sola e senza niente: in macchina, con la mia bici e il mio materiale per correre. Eppure nel giro di poco tempo sono riuscita ad affermarmi. Nel mio primo anno, ancora con i colori della squadra italiana, ho preso parte a 30 gare, conquistato un podio e diversi piazzamenti importanti. E così ho trovato almeno due squadre che mi volevano con loro. Nell’anno 2018 sono entrata a far parte del team Equano – Wase Zon. Mi sono trovata molto bene, ho partecipato a 120 gare in due anni, tantissime rispetto a quanto ero abituata in Italia.

Ed è arrivata anche la prima vittoria da professionista. Che emozione è stata e quali gli elementi che ti hanno consentito di conquistarla?
Un’emozione enorme. Dopo tanti podi, nel settembre del 2019 ho conquistato quella vittoria a Wenduine. La cercavo da tempo, sapevo di avere le potenzialità, ma evidentemente non credevo abbastanza nelle mie capacità. Quel traguardo mi sembrava vicino, ma pensare a una vittoria era una cosa troppo grande. L’aspetto mentale ha giocato tantissimo su di me. Tant’è che dal 2019 ho iniziato a farmi seguire da una mental coach. Abbiamo portato avanti un lavoro importante che ho dovuto metabolizzare e che mi ha permesso di accrescere la mia autostima, arrivare concretamente a credere in me stessa. In quello stesso anno ho conseguito la prima laurea in psicologia, la triennale in Scienze e tecniche psicologiche. Poi è arrivato il Covid e a inizio marzo si è bloccato tutto.
Come hai fatto a ripartire e com’è maturata l’idea di dar vita a una squadra tutta tua?
Purtroppo la pandemia ha reso tutto difficile e per il team di cui facevo parte non è stato più possibile andare avanti, per l’assenza di sponsor. Avevo due scelte: o cercarmi un’altra squadra in Belgio, oppure provare a crearmi qualcosa di mio… Mi sembrava una sfida molto grande, ma su consiglio e su spinta del mio ragazzo che vive nel mondo del ciclismo da anni, ho deciso di provarmi. Così, nell’ottobre 2020, è nato il nostro team, il Women Cyciling Project.
Chi ne fa parte e quali sono stati i passaggi per dar vita a questa nuova realtà?
Abbiamo optato per una squadra giovane, con ragazze di età massima 19/20 anni, oltre a tre cicliste più esperte. Siamo un team internazionale composto da sette italiane, tra cui ovviamente ci sono anch’io, e quattro straniere. Non è stato semplice, perché abbiamo dovuto muoverci per trovare gli sponsor, per coprire le spese principali, in primo luogo l’abbigliamento delle ragazze, caschi, scarpe, indumenti per le varie condizioni atmosferiche… Poi le macchine e i furgoni per spostarci, non abbiamo ancora tutto, ma poco per volta stiamo crescendo. I nostri sponsor principali sono italiani, biciclette Finotti e Molino Filippini. Abbiamo già preso parte alle prime gare in Italia e le nostre junior hanno partecipato a una tappa della Coppa del Mondo. La sede ufficiale della squadra è in Italia, ad Alessandria, ma la staff tecnico è belga.
Tu ripeti spesso che dietro a questo progetto ci sono prima di tutto dei valori. Perché?
Io penso che lo sport, anche quello di alto livello, possa essere veicolo per portare avanti valori e cause importanti. Certo, nell’agonismo sono i risultati che parlano, ma non concepisco uno sport “vuoto” di valori, come purtroppo spesso mi accede di vedere, soprattutto in figure che hanno un’alta visibilità mediatica.
Che i giovani e le giovani diventino campioni o no, per tutti lo sport deve poter veicolare messaggi di giustizia, autostima ed emancipazione. Soprattutto per noi donne.
Quanto è importante la dimensione psicologica?
Moltissimo. Lo vedo anche tra le mie ragazze della squadra. I problemi più grandi non sono negli allenamenti, ma negli ostacoli interiori che si trovano ad affrontare. Le insicurezze. Nel ciclismo gli allenamenti sono tutti abbastanza simili uno all’altro, se ti alleni a un certo livello vuol dire che ormai hai superato determinati step a livello di performance. Ciò che invece cambia è la l’approccio mentale. L’ho vissuto anch’io sulla mia pelle. Quando ho iniziato a godermi lo sport al cento per cento, fuori dalle gabbie mentali, tutto è cambiato.
Perché per una ragazza è ancora difficile vivere il mondo del ciclismo, soprattutto in Italia?
Perché purtroppo viviamo di retaggi assurdi. Nei confronti delle atlete c’è una dose alta di body shaming, attacchi e giudizi sulla loro forma fisica. In Italia è un atteggiamento molto frequente, che invalida molto le atlete. Ti dicono che se non pesi 45 kg non puoi essere una ciclista e questo è terribile. Le ragazze finiscono per preoccuparsi del proprio corpo, più che di come si sentono interiormente. Anche questi sono abusi psicologici… L’ambiente ciclistico in Belgio è diverso da questo punto di vista.
Quale consiglio daresti a una ragazza che si trova a subire un giudizio del genere?
Sono convinta che siamo noi donne a dover evolvere e cambiare il sistema. È una nostra sfida. Quello che dico è che non bisogna rimanere vittime, è necessario uscire da questo schema. Il rischio è di perdere il posto o la visibilità in squadra? È vero, ma meglio che perdere la dignità. Tante volte ho sentito dire alle giovani cicliste che non vogliono essere trattate come macchine. Perfetto, allora dove cercare di comportarvi come persone e lottare per la vostra dignità. Perché questo è importante nello sport, come nella vita.