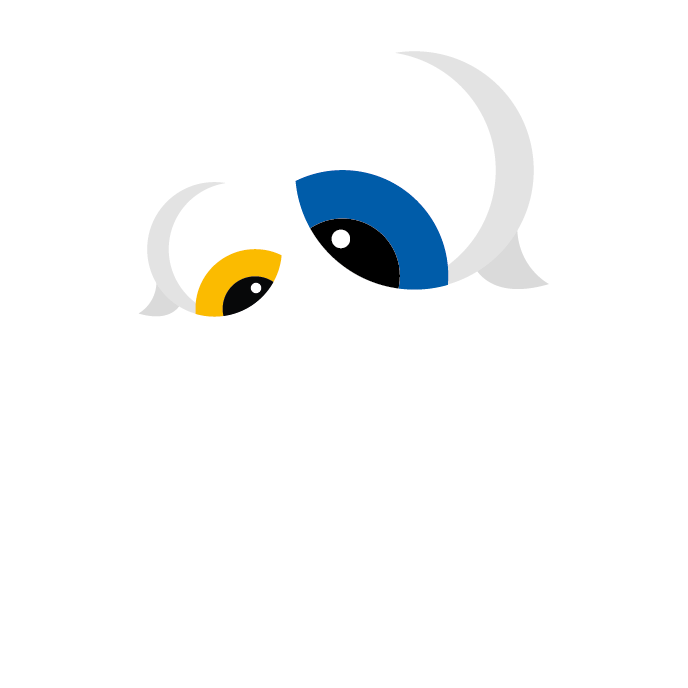Credere in un sogno, al di là di ogni confine
Che sotto ai piedi ci sia un prato, curato e rasato al punto giusto, oppure una distesa di terra battuta, di quel color ocra che illumina solo certe parti del globo. Una divisa o un numero sulla schiena, oppure un panno avvolto a coprire a malapena mezza gamba. L’importante è recuperare almeno qualche pallina, va bene anche vecchia e logora, un bastone per colpirla, e iniziare a correre. La storia di Valentina Quaranta per l’hockey su prato inizia quand’era bambina. A Bra, la città del destino, dove questo sport ha una tradizione di lunga data, sia in campo maschile che femminile. La città dove gli allenatori portano mazze e palline a scuola e, se hai del talento, la scalata ai vertici nazionali può diventare realtà. Ma quello di Valentina per l’hockey è un amore andato oltre ogni confine. Confine fisico o dell’immaginazione, arrivando su quella terra battuta e tra le mani dei bambini, delle donne, diventando strumento di unione ed emancipazione.
Valentina, l’hockey ti ha presa sotto braccio quando eri bambina e non ti ha ancora lasciata…
L’ho conosciuto alle elementari, grazie ad alcuni allenatori che venivano a scuola per insegnarlo. Mi è piaciuto, è stato amore a prima vista. E ho continuato affrontando tutte le categorie di età, arrivando in Serie A nella squadra maggiore quando frequentavo la terza media, e poi approdando anche in Nazionale, dove sono stata titolare diversi anni, fino al 2010. Con la Lorenzoni – la squadra femminile di Bra – ho vinto diversi scudetti, l’ultimo poche settimane fa, nel campionato indoor. Io ero in rosa anche se ormai passo più tempo all’estero che in Italia per lavoro. E comunque sono “vecchia” ormai e non più tanto in forma, per cui c’è gente più brava di me… ma sono riuscita a giocare qualche partita e a godermi il successo con le mie compagne.
Nel 2010 lasciavi la Nazionale, anche perché ti aspettava un’importante esperienza all’estero.
Dopo la laurea in Psicologia e l’esame di Stato mi sono presa un anno per svolgere il Servizio Civile, optando per l’estero. Ho scelto l’opportunità che meglio si combinava con le mie attitudini e competenze ed era quella offerta dal COPE (Cooperazione Paesi Emergenti), che cercava una figura con profilo socio-psico-pedagogico che supportasse un progetto sull’educazione dei bambini in età prescolare in Tanzania. Sono partita nel gennaio 2011 e sono rimasta tutto l’anno, in una zona del sud abbastanza sperduta, a sostegno di questo e di un altro progetto, dedicato all’empowerment economico delle donne, nel settore dell’artigianato tessile.
Ma poco prima di ripartire è successo qualcosa di assolutamente inaspettato…
Nell’ultima settimana mi sono trasferita, come gli altri volontari del Servizio Civile, a Dar es Salaam, la città più importante del Paese. Per un weekend con altri ragazzi avevo in programma di andare a Bagamoyo, meta turistica della zona. Eravamo su un bus, fermi nel traffico, come spesso succede nella grande città, quando a un certo punto il ragazzo che era con me mi disse: “Guarda! Stanno giocando a hockey!” Io non ci volevo credere, pensavo mi prendesse in giro. Mi sono girata e ho visto un gruppo di ragazzi che si stava allenando su un campo sterrato. Il mio amico mi ha convinta a scendere dal bus e ad andare a incontrarli. Da lì è partito tutto. Il gruppo era in realtà la squadra dell’esercito nazionale, allenata da Mnonda Magani. Mi sono presentata. I ragazzi e l’allenatore mi hanno accolta molto calorosamente, mi hanno prestato un paio di scarpe e una mazza, mi hanno fatto allenare con loro. Alla fine, l’allenatore mi disse: “Tra pochi giorni giochiamo in campionato, vieni!” E io: “Certo, sarebbe bello venire a vedervi giocare”. La sua risposta fu chiara: “No! Tu vieni e giochi con noi!”. Lì per lì non mi spiegavo come fosse possibile che una donna, per lo più straniera, potesse giocare in un campionato maschile, entrando in squadra così, da un giorno all’altro. Ma tant’è. La domenica mi presentai e giocai con loro.
Ma poco prima di ripartire è successo qualcosa di assolutamente inaspettato…
Nelle ultime settimane mi sono trasferita, come gli altri volontari del Servizio Civile, nella capitale Dar es Salaam. Per un weekend con altri ragazzi avevo in programma di andare a Bagamoyo, meta turistica della zona. Eravamo su un bus, fermi nel traffico, come spesso succede nella grande città, quando a un certo punto il ragazzo che era con me mi disse: “Guarda! Stanno giocando a hockey!” Io non ci volevo credere, mi sono girata e ho visto un gruppo di ragazzi che si stava allenando su un campo sterrato. Il mio amico mi ha convinta a scendere dal bus e ad andare a incontrarli. Da lì è partito tutto. Il gruppo era in realtà la squadra dell’esercito nazionale, allenata da Mnonda Magani. Mi sono presentata, mi hanno prestato un paio di scarpe e una mazza, mi hanno fatto allenare con loro. Alla fine, l’allenatore mi disse: “Tra pochi giorni giochiamo in campionato, vieni!” E io: “Certo, sarebbe bello venire a vedervi giocare”. La sua risposta fu chiara: “No! Tu vieni e giochi con noi!”. Lì per lì non mi spiegavo come fosse possibile che una donna potesse giocare in un campionato maschile, tra l’altro entrando in squadra così, da un giorno all’altro. Ma tant’è. La domenica mi presentai e giocai con loro.

Pochi giorni dopo sei tornata in Italia. Sei rimasta in contatto con la Tanzania?
Con Magan [come Valentina chiama Mnonda Magani, ndr] era stata intesa fin dal primo momento. Non potevamo perderci. Siamo rimasti in contatto, lui mi ha illustrato la situazione sportiva del Paese, le difficoltà di lavorare con i giovani e le donne, l’assenza di attività nelle scuole. Tornata in Italia ho ripreso a lavorare, ma il cuore era là. Iniziai una piccola campagna per raccogliere fondi e materiale sportivo da portare in Tanzania e quando il COPE mi offrì un’opportunità di un lavoro con base a Dar es Salaam, partii senza pensarci un attimo. Il contratto era di un anno, ma finii per restarci sette anni.
Sette anni in cui, oltre al tuo lavoro, hai creato un vero e proprio movimento legato all’hockey…
Nel febbraio 2013 mi imbarcai con due borse, una con i miei effetti personali, l’altra che conteneva solo bastoni, palle e materiale per giocare a hockey. Iniziai quasi subito, con l’aiuto di Magan, a tenere i primi allenamenti. Dopo appena un mese mi convocò Kaushik Doshi, segretario della Federazione di Hockey Tanzaniana, e mi disse: “Vorremmo mettere in piedi una squadra nazionale femminile, per partecipare all’African Cup of Nation, il campionato continentale per Nazioni”.
Non ci potevo credere… Accettai con entusiasmo, anche se sul momento non mi rendevo bene conto di cosa avrebbe comportato diventare allenatrice della squadra nazionale femminile della Tanzania. Anche perché non c’erano soldi, non c’erano campi di allenamento e… non c’erano nemmeno le giocatrici!
Come avete fatto?
Con Magan sono andata a contattare le ragazze con cui cinque o sei anni prima la Federazione aveva lanciato un primo tentativo di squadra nazionale, poi arenato. Un po’ erano militari, un po’ civili. Non fu semplice, ma nel giro di qualche settimana riuscimmo a mettere insieme 13/14 ragazze. Avevano una preparazione sportiva di base, ma facevano fatica anche solo a trovare il tempo per allenarsi.Molte non avevano nemmeno i soldi per prendere il bus, la maggior parte era sposata con figli… Ci vedevamo dalle 6 alle 9 del mattino, un po’ per il caldo, un po’ perché tutte (io compresa) dovevamo poi andare a lavorare. Ciononostante siamo riuscite a creare una squadra, siamo andate all’estero, giocando in African Cup, anche se la prima trasferta è stata sfortunata perché arrivammo a Nairobi in Kenya proprio il giorno dell’attentato al centro commerciale Westgate e la competizione venne annullata… Poi siamo state in Uganda e Zimbabwe per i campionati per club, in Sudafrica nel 2015 per tentare la qualificazione per i Giochi di Rio 2016. E nel 2017 anche in Namibia con l’Under 21 maschile e femminile, un viaggio lunghissimo, ma un’esperienza molto gratificante.
In questi anni il tuo intervento sul mondo dell’hockey locale è andato ben al di là delle competizioni e delle partite…
Diciamo di sì, perché parallelamente, sempre assieme ai miei collaboratori locali, ho lavorato per portare questo sport nelle scuole e creare un movimento capace di andare avanti con le proprie gambe. Abbiamo formato alcune delle ragazze della Nazionale come allenatrici in modo che potessero essere loro in prima persona a insegnare nelle scuole e far conoscere l’hockey.
Avete ricevuto aiuti in questa impresa?
Abbiamo sempre collaborato con la Federazione Nazionale della Tanzania, abbiamo avuto un sostegno importante dal mondo italiano dell’hockey, ma anche dall’Olanda, dove il mio sport è molto popolare. In particolare nel 2014 è venuta in Tanzania una squadra olandese per uno scambio interculturale attraverso lo sport. È nato un forte legame con loro che ci ha poi portati a dar vita a una Fondazione, la Twende Hockey, con lo scopo di raccogliere fondi e sostenere lo sviluppo di questo sport nelle scuole e tra i giovani. Il presidente è Nick Isbouts, amico e tecnico preparatissimo.
E i risultati si sono visti?
Abbiamo una decina di ragazzi e ragazze che lavorano come allenatori. E ben 1.500 ragazzini in quattro diverse Regioni del Paese che giocano a hockey. Il tutto coordinato da Alice Ongoro, allenatrice kenyota che vive in Tanzania da anni. Grazie a questo sistema abbiamo inaugurato anche quattro centri di allenamento dedicati all’hockey, in diverse zone di Dar es Salaam, per far sì che i ragazzi possano allenarsi anche dopo l’orario scolastico. Non sono come i campi che conosciamo qui in Europa, anzi, a dire il vero sono abbastanza “scassati”, ma è già un inizio.

Cosa può insegnare uno sport come il tuo in queste situazioni?
Come ogni gioco di squadra, aiuta a capire che bisogna lavorare tutti verso lo stesso obiettivo, mettersi in gioco e sacrificarsi per puntare al risultato comune.
Nel gioco le differenze sociali, culturali o economiche vengono messe da parte, per creare un’identità nuova, che è quella di gruppo.
Tu non hai abbandonato l’hockey giocato, qual è la differenza di ritrovarsi sul campo qua in Italia, con la Lorenzoni, e là in Tanzania?
Quando gioco in Italia, la sensazione è la stessa di quando avevo dieci anni, quando iniziavo a giocare le prime partite, come se tornassi ragazzina, anche se gli acciacchi fisici si fanno sentire… In Tanzania il mio ruolo è diverso, così come le sensazioni. Quando sei tu l’allenatrice tutte le emozioni sono amplificate, sia la gioia che la rabbia. La gioia di vedere la tua squadra esultare per un gol fatto, la gioia di vedere che i tuoi giocatori o le tue giocatrici si divertono, la gioia di vedere dei miglioramenti nel livello tecnico dopo ore di allenamento. Dall’altra la rabbia per ogni gol subito o mancato, o perché durante la partita sei fuori dal campo e ti senti “impotente” o non puoi sviluppare a pieno le potenzialità dei giocatori perché purtroppo ci sono sempre delle barriere sociali, economiche e culturali difficili da superare.
Il tuo intervento a livello sportivo ha avuto un ruolo prima di tutto sociale. Nei confronti dei bambini e dei giovani in generale. Ma soprattutto nei confronti delle donne…
Sì, non è così scontato in un Paese come la Tanzania far sì che le donne intraprendano un’attività sportiva. Sono contesti in cui, nonostante siano stati fatti grandi passi in avanti nell’emancipazione femminile, il ruolo della donna ancora oggi è socialmente emarginato, soprattutto nella presa delle decisioni. Le ragazze che si sono unite al gruppo della Nazionale e poi sono diventate allenatrici hanno vissuto un cambiamento nella percezione di sé, nell’autostima. Per la prima volta hanno sperimentato qualcosa di nuovo rispetto al percorso di vita che spesso per molte è già segnato. Hanno avuto l’opportunità di viaggiare, vedere posti nuovi, conoscere persone nuove, mettersi alla prova. Io ho cercato di spronarle, di incoraggiarle, uscire dalla passività che spesso la società patriarcale impone loro.
Da un paio di anni hai lasciato la Tanzania per seguire nuovi percorsi. Un master in Management of Development a Torino e un progetto da seguire in Sud Sudan. Pensi di portare l’hockey anche lì?
In Sud Sudan sono stata impegnata in progetti di cooperazione sempre legati all’empowerment della donna. A breve ritornerò per lavorare con una ONG di Torino, (CCM – Comitato Collaborazione Medica) che si occupa di salute materno-infantile e malnutrizione come coordinatrice dei progetti. Il Sud Sudan una squadra di hockey ancora non ce l’ha… Ma rispetto alla Tanzania le condizioni sono ancora più difficili. Tuttavia, non si sa mai, anche perché lo sport e la passione sportiva non hanno confini!