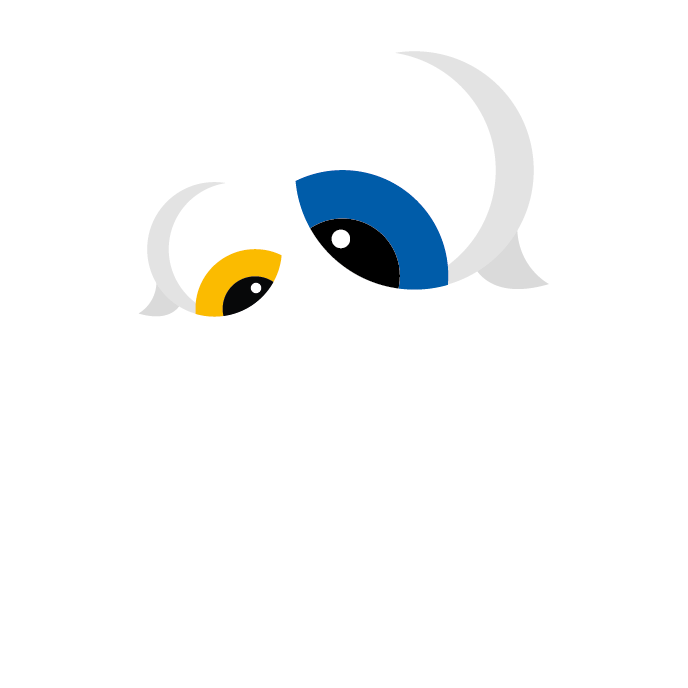Perché in strada non si imponga la regola del più forte
L’emergenza Covid-19 ha stravolto le nostre quotidianità, imponendo nuovi ritmi e nuove esigenze, creando un’emergenza anche dal punto di vista sociale ed economico. Durante gli oltre due mesi di chiusura di gran parte delle attività e dei centri urbani si è assistito a una “liberazione” o meglio a uno svuotamento delle strade, evidente soprattutto nelle grandi città, che ha portato anche al miglioramento della qualità dell’aria. Tuttavia ora si pone il problema di come affrontare la ripresa tanto attesa, anche dal punto di vista della mobilità, tenendo in considerazione che sarà necessario mantenere distanze di sicurezza in ambiente pubblico e quindi in ogni spostamento. L’alternativa sarà solo l’auto? Oppure si preferirà puntare sulle due ruote, con una scelta orientata anche alla tutela ambientale? E i mezzi pubblici che ruolo avranno?
Marco Scarponi è presidente della Fondazione Michele Scarponi, nata in onore del fratello, il grande ciclista vincitore del Giro d’Italia 2011, ucciso da un uomo alla guida di un furgone che non gli diede la precedenza svoltando a sinistra e lo colpì in pieno durante un allenamento mattutino in strada il 22 aprile 2017. La Fondazione, che si occupa di promuovere la cultura della mobilità sostenibile e di contrastare la violenza stradale, è tra i firmatari della lettera che alcune settimane fa diverse realtà italiane hanno inviato al governo per chiedere maggiore attenzione al tema della mobilità sostenibile e misure adeguate ad affrontare il post-emergenza. L’ultimo decreto emesso dal governo in parte risponde a queste richieste, ma c’è ancora moto da fare.
“Soprattutto perché – spiega Marco Scarponi – non si tratta solo di una risposta alla situazione che vivremo nei prossimi mesi, ma della necessità di iniziare finalmente anche in Italia a promuovere una cultura e un modo diverso di pensare la strada che non deve essere il luogo dove vige la regola del più forte. Perché la strada è di tutti“.
Chi era Michele, cos’era per lui la bicicletta?
Noi siamo cresciuti in collina e la bici è sempre stata uno strumento per fare sport. Una grande passione ma anche un grande sacrificio. Nostro padre regalò a Michele una bici da corsa per la prima Comunione e lui cominciò presto a vincere. A un certo punto in casa avevamo tante di quelle coppe che mia madre iniziò a regalarle perché non sapeva più dove metterle. Michele è sempre rimasto legato alla sua famiglia e alla sua terra, tanto che, anche quando andò a vivere in Veneto per il ciclismo, non ha mai cambiato residenza. I nostri genitori andavano a trovarlo ogni fine settimana. In carriera ha vinto tanto, dalla categoria juniores fino al professionismo. Ma il ciclismo è duro, a vincere è sempre e solo uno, gli altri perdono tutti. E negli anni Michele ha subito anche molte sconfitte.
Ciclismo sport di gambe, ma anche sport di testa.
Certo, soprattutto quando – come è successo a lui – dopo anni in cui ricopri il ruolo di capitano, ti trovi a essere gregario. Una sfida difficile da accettare, ma che ha richiesto tutta la maturità e la tenacia che facevano di Michele un grande uomo. Lui, che non voleva mai perdere, si è trovato a cedere il passo per aiutare un’altra persona a vincere, il suo capitano, Vincenzo Nibali.
C’è chi lo ha definito “il gregario più forte del mondo”. E a rappresentarlo c’è un episodio molto iconico, rimasto nella memoria di tanti, la tappa del Giro del 2016 Pinerolo-Risoul.
Era il 27 maggio, Michele era in testa e passò in solitaria la cima Coppi, in mezzo a muri di neve. Poi però in discesa, su richiesta della sua squadra – la Astana – si fermò, piede a terra, per attendere Nibali e lanciarlo verso la vittoria di tappa, preludio della vittoria del Giro. Una scena antica e mitica: fermarsi e aspettare, sacrificando la propria vittoria. Un gesto non scontato, una decisione forte.
Quel piede a terra significa molto, ha un valore anche altamente simbolico
Abbiamo deciso di utilizzare quell’immagine per il logo della Fondazione. Il piede a terra significa proprio questo.
La tua vittoria personale non è la cosa più importante. Fermarsi, aspettare gli altri non è un gesto di debolezza, ma un gesto di forza. E così dovrebbe essere sempre, nella vita, sulla strada, tutti i giorni.
Il nostro impegno come Fondazione ora è chiedere al più forte, l’automobile, di mettere il piede a terra per aiutare l’altro, nell’interesse di tutti.
Quello della mobilità sostenibile è un tema complesso e in Italia sembra non riuscire ancora a trovare il giusto spazio e la giusta rilevanza. Perché?
Noi siamo una Fondazione giovane, nata due anni fa. In questo breve lasso di tempo abbiamo girato molto, conosciuto tante realtà che portano avanti una missione importante, associazioni che si battono per una mobilità a misura d’uomo. Però purtroppo la visibilità è ancora scarsa. L’Italia vive una paradosso: è uno dei Paesi che ama di più il ciclismo al mondo e che annovera campioni straordinari nel passato e nel presente, insieme a Francia, Belgio, Spagna. Eppure da noi è quasi impossibile trasmettere l’amore per la bicicletta in strada. Basti pensare a quante pubblicità vediamo in televisione relative alle auto e a quante – nessuna – che vediamo legate al mondo delle due ruote. E invece siamo proprio in una fase storica in cui, per motivi anche ambientali, bisognerebbe incentivare l’uso della bicicletta.
L’auto sembra essere qualcosa di intoccabile.
Sì, anche nel racconto mediatico, non esiste ironia sull’automobile. L’auto non si può mettere in discussione. È uno status symbol. Eppure in strada è l’auto che uccide. Ogni anni si registrano oltre 3.000 vittime sulla strada, ma per la maggior parte non si tratta di ciclisti o pedoni – che comunque pagano un grande prezzo – bensì degli stessi automobilisti, motociclisti, camionisti.
È proprio come se in strada vigesse la legge del più forte?
Io faccio spesso un esempio, che nasce dal mio impegno come educatore di ragazzi disabili. Ricordo che quando facevo con loro dei laboratori di teatro, questi ragazzi dovevano salire sul palco e ogni volta dovevamo prenderli in braccio sulla carrozzina e sollevarli per farli salire, provocando anche umiliazioni. Solo perché il palco non aveva una pedana che permettesse loro di muoversi in autonomia. Sulla strada manca proprio quella “pedana”. Le piste ciclabili sono poche e spesso costruite male, la strada è progettata a misura d’auto e non favorisce l’autonomia del soggetto più fragile.
Avere strade che tutelano il più debole garantirebbe una vita migliore per tutti, anche per il più forte .
Ora nell’ultimo decreto seguito all’emergenza coronavirus, il governo ha varato una serie di misure a favore della mobilità sostenibile. Il come vivere il tempo fuori casa – di conseguenza – la mobilità, saranno temi chiave da affrontare?
Sì, c’è voluta la pandemia per avere delle piste ciclabili o un incentivo all’acquisto delle bici. Diciamo che quello che sta succedendo è abbastanza rivoluzionario, ma al tempo stesso pericoloso. Mentre altrove i mezzi pubblici sono incentivati, da noi il messaggio è: “Meglio che non li prendiate”. Negli anni le politiche non si sono mosse a favore dell’utilizzo dei mezzi pubblici: basta pensare a quanto fatto sui treni dove, al di là dell’alta velocità, il trasporto su rotaia è stato molto penalizzato. Ora, pensare di risolvere la situazione puntando solo sulla bicicletta come alternativa all’auto è difficile. È necessario invece affiancare ad essa l’investimento sui mezzi pubblici, componente fondamentale per la mobilità sostenibile. Bisognerebbe aumentare il numero di treni, le corse degli autobus. Ripensare completamente la nostra mobilità nel complesso.

Con i più giovani si riesce a parlare di questi temi? Che sensibilità hanno?
Nel 2019 ho incontrato quasi 7.000 ragazzi, dalle scuole dell’infanzia fino all’università. E il problema non sono loro, ma gli adulti. I più giovani sarebbero subito pronti a imbracciare la bicicletta, il monopattino, anche perché nelle nuove generazioni c’è una maggiore sensibilità al tema ambientale. Tuttavia, quando incontrano noi non sono una tabula rasa, ma si portano dietro insegnamenti spesso errati e hanno già un’esperienza di violenza nei comportamenti: genitori che guidano guardando il telefono, che non rispettano i limiti di velocità. Gli interventi sulla sicurezza stradale a scuola non dovrebbero essere “eventi” come ora, senza una visione e una continuità, ma dei percorsi strutturati e condotti da professionisti.
In quest’ottica voi avete anche prodotto un documentario.
Si chiama “Gambe”. Con le prime manifestazioni in memoria di Michele, chiesi a un gruppo di amici di fare delle riprese, per fissare la memoria di quanto stavamo vivendo. E poi ci abbiamo lavorato sopra e abbiamo raccolto interviste a figure che potessero affrontare vari temi, dal ciclismo vissuto sotto diversi punti di vista alla violenza stradale. Ci sono campioni amici di Michele, ma anche familiari delle vittime o una figura straordinaria come l’architetto Matteo Dondè, esperto in pianificazione della mobilità ciclistica, moderazione del traffico e riqualificazione degli spazi pubblici.

Quanto è difficile far passare i messaggi che portate avanti?
Spesso durante gli incontri a cui partecipiamo si pronuncia la parola “rispetto”, in frasi come “anche i ciclisti devono avere rispetto dei pedoni”, “i ciclisti devono rispettare le regole”. Vero. Ma il problema concreto è che il nostro codice della strada è stato pensato e concepito per creare fluidità nel traffico automobilistico e che in Italia l’auto ancora è considerato un bene necessario, le statistiche ci dicono che abbiamo quasi 70 auto ogni 100 abitanti. E purtroppo, anche in casi di episodi mortali, si tende a non attribuire colpe e responsabilità. C’è addirittura chi fa campagne contro gli autovelox, come se fosse qualcosa di inaccettabile chiedere di rallentare, diminuire la velocità, sanzionare perché si va troppo veloce.
E anche se si fa fatica a usare il verbo “uccidere” quando si parla di episodi avvenuti in strada, la verità è che la velocità uccide.
Qual è la speranza per il futuro?
La storia di Michele vogliamo che serva a innescare una serie di spinte positive. Tra queste, trasmettere l’idea dello sport come strumento per imparare a stare insieme agli altri nel rispetto delle regole comuni; promuovere la bicicletta come mezzo di locomozione giusto, sano e pulito; l’importanza di muoversi a tutela dei più fragili, sia sulla strada che in altri contesti sociali; ricordarsi delle vittime della violenza stradale e sostenere i loro familiari. E per questo ci muoviamo guardando al futuro. Il nostro sogno è avere delle città a misura d’uomo e non di auto, anche dal punto di vista urbanistico. E poi ricordarsi che l’imposizione della regola del più forte non può essere la scelta di una società sana.